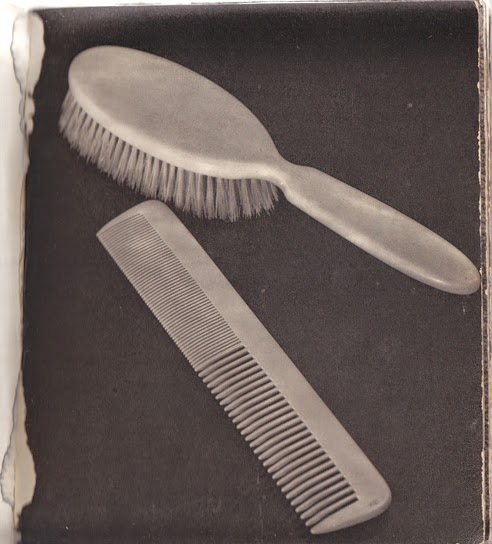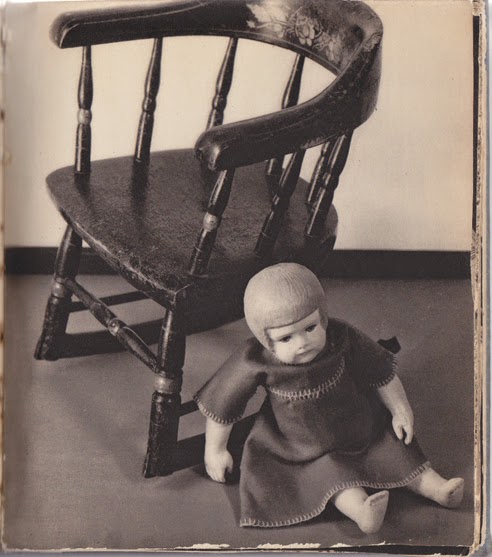Qualche anno fa,
Massimo Scotti, che è ricercatore di Letteratura francese e insegnante presso le università Kore di Enna e lo Iulm di Milano, mi raccontò di uno studio che stava svolgendo: il tema era quello dei fantasmi nella storia della letteratura, o meglio delle case infestate. Mi sembrò un argomento magnifico per un libro illustrato. E pensammo subito che
Antonio Marinoni sarebbe stato perfetto per illustrarlo.
L'idea di
Case stregate è nata in questo modo. Da quel momento, è trascorso qualche anno. Massimo intanto, nel settembre 2013, ha pubblicato con Feltrinelli il suo studio:
Storia degli spettri. Fantasmi, medium e case infestate fra scienza e letteratura, la cui lettura senz'altro vi consigliamo ( e se vi innamorate della sua scrittura sappiate che ci sono anche
Ces vipères de lueurs. Il mito ofidico nell’immaginario valériano, 1996;
Sul mare degli Dei. Mitografia dell’isola di Capri, 2002;
Gotico mediterraneo, 2007).
A un anno di distanza, ecco la versione narrativa e visionaria di questo colto lavoro, un libro che prende per mano il giovane lettore per condurlo con sapienza, ironia e sentimento attraverso la dimensione sfuggente, inquietante e romantica dell'invisibile e delle sue leggendarie, romanzesche manifestazioni: i fantasmi. Un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso epoche e luoghi di cui i fantasmi portano i segni: perché per quanto qui si abbia a che fare con l'eternità, un fantasma della Roma antica è certo molto diverso da un fantasma americano di due secoli fa. Verità che emerge immediata e prepotente dalle immagini del libro che, insieme al testo, raccontano atmosfere, personaggi, stili, architetture, con la maestria e il rigore a cui ci ha abituato Antonio Marinoni. Raffinate, forti, suggestive, cariche di suspance e mistero, le immagini di Antonio nascono da una lunga e attenta ricognizione dell'iconografia legata al tema dei fantasmi e delle case stregate.

Che l'immaginario di questo scrittore e di questo illustratore siano straordinariamente affini, non è una novità, come dimostra
L'ora blu, storia di un incontro fra un viaggiatore inglese e due fantasmi emersi da un diario settecentesco durante un viaggio in treno attraverso le alpi svizzere. E in
Velluto. Storia di un ladro, con testo di
Silvana D'Angelo, il tema del passato e delle presenze nascoste che abitano interni domestici e si manifestano di tanto in tanto nel presente, è al centro del lavoro figurativo di Antonio Marinoni. Così come in
Un chicco di Melograno. Come nacquero le stagioni, incentrato sul mito di Persefone e Demetra, Massimo si avventura con la protagonista nel regno delle tenebre, fino ad Ade, oscuro signore di quei luoghi (illustrazioni di
Pia Valentinis).
Così oggi, abbiamo pensato di rivolgere qualche domanda a Massimo e Antonio per capire quali esperienze personali, letterarie e artistiche si intreccino in questo libro e siano alla base del loro immaginario così prossimo a queste dimensioni.
Massimo, quando è cominciato il tuo interesse per questi temi?
Come si dice, mi interessano “da sempre”. Da piccolo, per tanti motivi, l’idea della morte ti viene nascosta. Con il risultato di renderla arcana – se possibile ancor più di quanto non lo sia già di per sé – e molto poco chiara. Dove vanno i morti, che ovviamente non sono più accanto a te? Risposta tipica: in Cielo, con gli angioletti. Sì ma allora come mai si accompagnano i morti al cimitero? Cosa resta nella tomba e cosa va in Cielo? I bambini si pongono domande del genere, di solito, e siccome nessuno lo sa davvero, le risposte sono contraddittorie e la fantasia si scatena. Da questo tipo di interrogativi e di misteri può nascere l’interesse per questi argomenti, fino al punto in cui cerchi di “saperne di più”. Così capita di addentrarsi in una lunga ricerca, come ho fatto io con la
Storia degli Spettri e ora con le
Case Stregate. Dato che il tema non è dei più allegri, ho cercato di mettere nei due libri almeno un tocco di ironia, tanto per tirarci tutti un po’ su di morale.
Antonio, a quando risale la tua passione per architetture e interni?
È una passione nata quando ero molto piccolo.
Secondo la vostra esperienza, per quale ragione la dimensione dell'invisibile, del mistero, riguarda così da vicino quella dell'arte?
M.S. L’arte e la cultura, l’ho sempre pensato, servono a tener lontano il vuoto. Che può essere il vuoto di un pomeriggio fatto di noia, oppure il vuoto di risposte a cui accennavo prima. L’arte è misteriosa (ho paura di dire una cosa tanto evidente da risultare banale), è alla radice stessa del mistero, eppure è tanto umana e vitale da manifestarsi alle origini stesse dell’esistenza; i dipinti straordinari delle grotte di Altamira o di Lascaux dimostrano che l’uomo, quando aveva poco più di quanto gli serviva per non morire di fame o di freddo, provava già il bisogno di forgiare oggetti artistici, per comprendere la realtà che lo circondava, riproducendola. E mi verrebbe da aggiungere che non lo fa solo l’essere umano: ricordi, Giovanna, quando scrivevamo insieme il
Manuale di Re Leone? Scoprivamo che certe specie di uccelli, per esempio, erano in grado di allestire magnifici giardini con foglie, rami e petali di fiori, per conquistare i loro oggetti d’amore, perché – altra cosa ovvia – anche l’amore ha a che fare con l’arte, proprio come ogni mistero, compresa la morte.
A.M. Perché l’immagine artistica è in grado di suggerire l’invisibile. L’arte, sin dall’antichità, ha ricercato i modi per raffigurare l’invisibile (il divino, i miti, i sogni, i mondi immaginari) così da facilitarne la comprensione, rendendolo visibile. Da qui: una lunga tradizione iconografica, alla quale cerco sempre di fare riferimento.
In che modo avete affrontato, l'uno con parole e l'altro con immagini, il racconto dell'invisibile?
M.S. Nel mio caso la questione è proprio questa: un fantasma è un’anima (che nessuno vede) a rendersi in qualche modo “visibile”, almeno a metà, in modo evanescente; è questa la cosa inquietante. Lo “spirito” per definizione non si vede – perché è privo di corpo – ma può diventare “spettro” o “fantasma”, cose che hanno a che fare con la luce (pensiamo allo “spettro solare”) e con il fenomeno visivo, in vari modi e a vari gradi. Ho imparato molte cose sulla definizione di questi termini e di questi concetti durante un interessantissimo convegno che si è appena svolto a Rocca Grimalda (Ovada), dal titolo
Fantasia e Fantasmi, organizzato da Sonia Barillari e Martina Di Febo, che sono state così gentili da permettermi di presentare in questa occasione proprio le
Case stregate.
A.M. Ho cercato di suggerire le atmosfere. Mi sono concentrato sulle ambientazioni notturne e, tramite la composizione, il chiaroscuro e il colore, ho tentato di rendere il tono emozionale del racconto. Penso che l’atmosfera possa guidare la nostra percezione e favorire il nostro coinvolgimento nella storia. La meta, che come illustratore sento altissima e difficile da raggiungere, sarebbe quella di riuscire a ricreare e a trasmettere un’emozione.
Da sempre l'uomo immagina e sente che i luoghi oltre che da abitatori sono abitati da presenze. I luoghi sono abitati cioè dai tempi che hanno attraversato e dalle persone che hanno appartenuto a quei tempi. Quanto la relazione con il passato conta nel vostro lavoro?
M.S. L’ho capito, quasi tangibilmente, proprio a Rocca Grimalda. Un luogo scelto apposta dalle organizzatrici perché ha un’atmosfera del tutto singolare, piena di “presenze”. Quando parliamo di atmosfera ci riferiamo proprio a questo: è come se l’aria avesse un peso diverso, fosse più densa o più sottile, piena di voci silenziosissime, di musiche non udibili, di colori non definibili e di tante caratteristiche non spiegabili; si crea un’atmosfera durante una cena piacevole, ma può capitare di trovarsi in un luogo dall’atmosfera sinistra. C’è qualcosa che non vediamo o non percepiamo, almeno con i nostri sensi; ma sappiamo che c’è, perché “lo sentiamo”. In un castello sappiamo che è presente la storia, perché le mura antiche ci parlano del passato; pensiamo inevitabilmente a chi c’è stato prima di noi, percorriamo le stanze su cui si sono posati altri passi, il tempo trascorso è quasi palpabile; la stessa cosa si prova in un museo o in una galleria d’arte: pittori e scultori hanno lasciato traccia della loro esistenza negli oggetti che hanno realizzato (proprio nel senso di “rendere reali” per i nostri occhi). In una biblioteca ci sono migliaia, milioni di voci che parlano ancora, chiuse nelle pagine dei libri, c’è un pensiero molteplice che aleggia, è un concerto di sussurri, ma anche di voci potenti; in questo senso si può dire che lo spirito sia sempre vivo e presente, impossibile da cancellare.
A.M. Mi interessano molto le tracce del passato e mi sento legato affettivamente agli oggetti familiari tramandati attraverso diverse generazioni. Anche quando disegno il riferimento a quanto è stato fatto in passato è spesso presente. Mentre lavoravo alle illustrazioni per Case stregate ho riflettuto più volte su certe opere di Léon Spilliaert, quelle più cupe e visionarie, e su certi lavori di Füssli, di Redon e di Delvaux, sulle fotografie di Deborah Turbeville e di Mimmo Jodice (che ho citato due volte nel libro) e sulle immagini di alcuni film, come The Innocents di Jack Clayton.
Che cos'è per voi un fantasma?
M.S. Probabilmente la mancata elaborazione di un lutto. Lo intuivo alla fine della
Storia degli Spettri: il fantasma è l’immagine della perdita. Se ci credi, vedere un fantasma significa trovarsi di fronte a qualcosa che non c’è più, non appartiene più al nostro spettro visivo consueto (e non è un gioco di parole), ma rimane lì ancorato all’esistenza, non riesce ad andar via, per motivi oscuri. Non ho mai visto un fantasma, però se mi capitasse vorrei trovare il coraggio di chiedergli: “Perché sei qui? Cosa posso fare per aiutarti?”. Perché secondo la tradizione anche loro vorrebbero andar via, solo che non trovano la strada per allontanarsi. Ho letto un articolo su
Internazionale, qualche settimana fa, che mi ha molto turbato. Raccontava di un sacerdote spiritista chiamato in Giappone, nei luoghi colpiti dallo tsunami. Sentiva la presenza di anime sperdute. I tanti morti provocati dal cataclisma erano stati strappati alla vita troppo in fretta. Ma rimanevano lì, come in trappola. Alcuni non sapevano nemmeno di essere morti. Il sacerdote aveva il compito di aiutarli ad “andare via”. E lui – così riferiva – riusciva a recidere i legami fra quei “non morti” e l’esistenza, perché potessero liberarsi e salire – sono sempre parole sue – “verso la luce”.
A.M. Penso ai fantasmi con leggerezza. Per me sono come quelle spiritose presenze che agiscono nel film Fantasmi a Roma, che mi ha incantato da bambino.
 |
| Disegno preparatorio per Poveglia. |
 |
| Disegno preparatorio per Poveglia. |
Vi è mai capitato di aver pensato di essere stati testimoni di fatti non riducibili attraverso a una spiegazione razionale?
M.S. No, l’ho detto spesso, non mi è capitato mai. Per questo forse sono così fissato. Ero un bambino molto credulone, sempre convintissimo dell’esistenza di fate, spiriti, UFO, ma nessuna presenza inspiegabile si è mai degnata di farmi visita. Forse perché pensavano: “Con questo non c’è gusto, ci casca subito”, oppure: “Inutile scomodarsi, tanto ci crede lo stesso”. Forse qualche amico buontempone, o qualche società spiritica, prima o poi mi organizzeranno una bella messinscena fantasmatica, giusto per farmi contento, e per farmi spaventare un po’.
A.M. Meglio non dire.
 |
| Disegno preparatorio per Poveglia. |
 |
| Prova colore per Poveglia. |
Cosa vi ha interessato di più nel corso del lavoro per Case stregate?
M.S. Per quanto mi riguarda, immaginare cosa Antonio avrebbe fatto delle mie parole, come le avrebbe interpretate; cercavo di spiegargli i colori che immaginavo, glieli descrivevo, sempre un po’ umiliato dal fatto che le parole, Cenerentole, possano dire così poco delle immagini; mi è piaciuto moltissimo vedere la trasformazione dei bozzetti in tavole, e seguire il lavoro lenticolare, paziente, affascinante, che andava facendo intorno a idee (vaghe), concetti (confusi) e leggende (oscure) che la tradizione ha conservato così ostinatamente. Questo è l’interrogativo persistente che ci propone l’immaginario: ma se sappiamo che queste cose non sono vere e razionali (come i fantasmi, appunto), perché la gente ci crede da secoli e millenni? Un’ultima cosa, molto interessante: se davvero non esistessero, questi fantasmi, se fossero esclusivamente fantasie, ognuno se li inventerebbe un po’ a modo suo, e invece, no. Ogni storia, recente o antichissima, di qua e di là dal globo, in Giappone come in Europa, presenta sempre, eternamente, le stesse strutture: i fantasmi, da che mondo è mondo, si manifestano sempre secondo le stesse leggi e nelle identiche modalità. Questo è davvero strano, no?
A.M. Ho trovato interessante studiare questi micro-racconti per immagini, che integrano il testo di Massimo e che si risolvono nello spazio di una o due pagine, così brevi (e pur completi) che li ho immaginati come trailer di possibili e più estese storie.
Poi, mi diverte sempre la raccolta della documentazione per la scelta dei personaggi e delle ambientazioni: fatta per selezioni successive, è una specie di casting.
 |
| Prove per le grafica di copertina. |
 “Grazie di avermi fatto conoscere questo libro.”
“Grazie di avermi fatto conoscere questo libro.”
 I bibliotecari e la biblioteca sono, concludendo, la memoria dei libri, e ci sono libri che meritano proprio di essere ricordati.
I bibliotecari e la biblioteca sono, concludendo, la memoria dei libri, e ci sono libri che meritano proprio di essere ricordati.