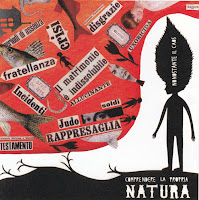La mostra, curata da Giorgia Atzeni (che a voi, come a noi, è più nota come illustratrice e instancabile animatrice della scena culturale cagliaritana) e Barbara Cadeddu in sinergia con la biblioteca che l’ha ospitata nella splendida Cappella tridentina, propone una selezione di trentuno volumi figurati del Quattrocento e del Cinquecento.
La mostra è il risultato di due anni di ricerca che ha prodotto anche un saggio bibliografico: Letteratura e immagini in tipografia. Il libro illustrato in Sardegna nei secoli XV e XVI
offre un significativo repertorio iconografico utile alla conoscenza della cultura figurativa del Rinascimento attraverso i volumi presenti nell’Isola.
Essendo fanaticamente appassionati di libri antichi figurati e consapevoli della forte relazione che lega la tradizione iconografica storica ai picture book
di oggi, abbiamo chiesto alle curatrici di condividere con noi e con voi alcune loro considerazioni.
[di Giorgia Atzeni e Barbara Cadeddu]
 |
| Le autrici del post all'inaugurazione della mostra. |
Tra i secoli XV e XVI, si andò affermando l’uso di inserire le figure nei libri: l’illustrazione, infatti, venne intesa dagli editori come strategico paratesto, in grado di conquistare i lettori e assicurare il buon successo commerciale dei volumi. Il libro a stampa non va infatti inteso solo come veicolo della cultura letteraria, ma anche nella sua veste di “oggetto di visione”, un contenitore di immagini incise, portatore di modelli e fonte d’ispirazione per gli operatori artistici; offre, inoltre, lo spunto per delineare il percorso storico delle arti e tecniche a esso collegate e della loro trasmissione. Negli ultimi decenni del Quattrocento, le innovazioni figurative trovarono spazio nei corredi librari più che nei fogli sciolti: l’illustrazione fu un campo fertile per il progresso delle tecniche e degli stili; attraverso la sua pratica gli artisti entrarono in più stretto contatto con il mondo dell’Umanesimo, con gli autori e gli editori, dando vita a un nuovo orizzonte d’immagini.
 |
Uno dei monumenti bibliografici in mostra, l'opera virgiliana
stampata a Lione nel 1526. |
Fermamente convinte che le raffigurazioni impresse a fronte del testo letterario integrino la parola e diano un valore aggiunto alla scrittura, rendendo unica la pagina letteraria, ci siamo impegnate per rendere accessibile questo tesoro nascosto alla cittadinanza cagliaritana e non solo.
Il primo dato significativo è rappresentato dalla quantità di volumi figurati presenti alla Biblioteca Universitaria: circa 5238 incunaboli e cinquecentine, di cui 1934 illustrati. Questo pregevole fondo antico è costituito dalla biblioteca privata di re Carlo Emanuele III di Savoia e da fondi acquisiti a seguito della soppressione dell’Ordine dei Gesuiti nel 1773.
 |
L'Anatomia di Berengario da Carpi, in un'edizione
veneziana stampata nel 1535. |
I libri provengono dai maggiori centri editoriali dei secoli XV e XVI, quali Venezia, Roma, Firenze, Lione, Parigi, Basilea, Colonia, Anversa e Francoforte, ma anche da centri minori, come Vico Equense e Cagliari, città in cui la prima tipografia stabile s’impianta solo nel 1566.
L’analisi critica degli esemplari ha permesso l’identificazione sia di monogrammi, immediatamente riconducibili ad artisti di calibro, sia di cifre stilistiche tali da permettere l’attribuzione dei cicli figurativi esaminati a specifici
milieu culturali.
 |
| Visitatori concentrati la sera dell'inaugurazione. |
Spesso le tavole sono anonime e frutto di operazioni collaborative: al
delineator o
inventor spetta il disegno iniziale, mentre allo
sculptor l’intaglio dell’immagine sulla matrice lignea o l’incisione, per esempio a bulino, su quella calcografica. La conseguenza è la scarsità di notizie sugli incisori dovuta anche alla mancanza di firme sulle stampe: l’anonimato ricorre, infatti, nella maggior parte delle incisioni esaminate.
È il caso di uno dei primi volumi interamente illustrati nella storia del libro italiano, le
Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini (Roma, 1481), che fissa le iconografie di dodici profeti e altrettante sibille, portatrici delle coeve espressioni dell’arte italiana maggiore, con lontane ascendenze donatelliane o castagnesche, fonte di modelli figurativi per gli artisti del momento. Ma anche del
Supplementum Chronicarum del 1492, aperto da un frontespizio raffigurante “I giorni della Creazione” in cui illustrazione e decorazione si fondono armonicamente, seguito da due tavole a mezza pagina (vedi sotto: Adamo ed Eva cacciati dal paradiso terrestre e Caino e Abele, anche
qui da un’edizione volgarizzata coeva) in cui si riscontrano forti analogie con la produzione pittorica dei grandi artisti veneziani della fine del Quattrocento.
Resta anonimo anche lo xilografo che illustra l’edizione della Calandra (Venezia, 1526 - vedi sotto). Le tavolette multi-episodiche, caratterizzate da un intaglio semplice ed essenziale, ma ombreggiate da fitti tratti diagonali, presentano un linguaggio assimilabile a quello di incisori operanti nella laguna nello stesso giro d’anni.
Oltre alla presenza di artisti dai profili biografici poco definiti, ma di qualità riconosciuta, come il cosiddetto Maestro del Virgilio di Grüninger, comunque, abbiamo rilevato anche nomi eccellenti, come Albrecht Dürer, probabilmente coinvolto con il suo maestro Michael Wolgemut e Hans Pleydenwurff nel ciclo del
Liber Chronicarum di Hartman Schedel (vedi sotto).
È invece accertata la mano di Hans Sebald Beham nelle
Biblicae Historiae, unico volume della collezione in coloritura coeva (vedi sotto, ma anche un altro esemplare, sfogliabile,
qui).
E si individua il tratto inconfondibile dello svizzero Jobst Amman, xilografo e acquafortista, che firma il
Von Kayserlichem Kriegsrechten (vedi sotto, ma anche un esemplare venduto da Christie’s
qui).
A volte gli operatori grafici collaborano in squadra a grandi progetti editoriali, come nel caso della
Cosmographia universalis di
Sebastian Münster, all’Universitaria in lingua francese (parzialmente consultabile
qui), nelle cui tavole è possibile riconoscere le sigle di ben sette xilografi: Hans Holbein il giovane, Urs Graf, David Kandel, Jakob Clauser, Heinrich Holzmüller e Christoph Schweicker o Stimmer, il monogrammista HSD, e Hans Rudolph Manuel “Deutsch”; e in quello delle
Humanae salutis monumenta, edite dal Plantin nel 1571, che vede all’opera Crispin van der Broeck, Pieter Huys, Pieter van der Borcht e i fratelli Jean, Jerome e Anthoine Wierix (vedi sotto).
Tra gli incisori italiani, invece, troviamo i nomi insigni di Lucantonio degli Uberti, Matteo Pagano da Treviso, Mario Cartaro, ma anche di altri meno conosciuti, come Girolamo Gaieta che sigla, con una certa consapevolezza del proprio ruolo di
sculptor, le tavole della
Decada de la Passion di Juan Coloma, per i tipi di Nicolò Cañelles, canonico cui dobbiamo la prima officina tipografica stabile in Sardegna, presso il quale il Gaieta aveva un ruolo di factotum (vedi sotto).
Ai nostri fini, più che per eccezionalità bibliografica, vale la pena di segnalare la presenza di un’edizione del
De Humana Physiognomonia scritta dal drammaturgo napoletano
Giovanni Battista Della Porta per i torchi dell’editore aquilano Giuseppe Cacchi, uscita nel 1586 a Vico Equense (molto, interessante materiale iconografico si trova
qui, inserito in cornici insopportabilmente brutte).
L’opera analizza le varietà fisionomiche dell’uomo, individuandovi corrispondenze con quelle animali attraverso un ricco corredo di immagini costituito, per la maggior parte, dall’accostamento di volti umani e fattezze di animali che dimostra la somiglianza e le analogie caratteriali, secondo il principio dello zoomorfismo.
In qualche modo, il volume anticipa le teorie lombrosiane e, se pensiamo alla produzione editoriale dei nostri giorni, è precursore di quel bell’albo
Ritratti famosi di comuni animali, di Svjetlan Junakovic, edito dalla spagnola OQO in edizione originale e riproposto in Italia da Logos. Siete d’accordo con noi cari Topi?
Noi siamo, incontestabilmente, d’accordo con voi, care ricercatrici.
[Le foto sono di Gianni Atzeni, che ringraziamo per avercele messe a disposizione]