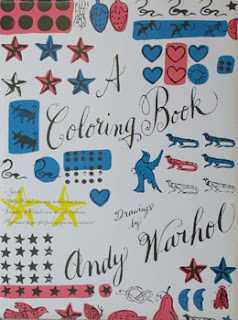|
| Rossana all'opera a Sàrmede. |
[di Rossana Bossù]
Quest’anno volevo partecipare a un corso d’illustrazione ma sentivo la necessità di trovare un insegnamento che andasse oltre la realizzazione di una o due immagini.
Volevo trovare un corso in cui l’illustrazione fosse pensata e realizzata in funzione del libro.
Il corso Progettare libri tenuto da Paolo Canton l’avevo già fatto, anche il Progettare Libri 2. Dovevo cercare altrove.
Alla Bologna Children’s Book Fair, presso lo stand delle Immagini della fantasia, la scuola d’illustrazione di Sarmede ho assistito alla presentazione del corso Illustriamo un libro di Valeria Bertesina.
Mano a mano che Valeria parlava con quel suo tono preciso e calmo io rimanevo impigliata tra le sue parole. L’obiettivo del corso era la realizzazione di una o più illustrazioni per un libro che sarà pubblicato dalla casa editrice Tassotti a dicembre 2015. Il libro contiene una piccola raccolta di poesie scelte tra i classici.
 |
| Al lavoro, nonostante il caldo, nella storica sede di Rugolo. |
Avevo trovato il corso adatto a me, c’era solo un problema, alla fine della presentazione, i posti disponibili erano esauriti.
Non mi sono data per vinta, infiltrata nella lista d’attesa e grazie alla disponibilità di Valeria e dell’editore Tassotti, che ha acconsentito ad aggiungere un quartino al libro, sono riuscita a partecipare.
Un mese prima dell’inizio di Illustriamo un libro, Valeria ha inviato agli allievi il testo delle poesie in modo che potessimo leggerle, sceglierne un paio e cominciare a riflettere sulle possibilità d’interpretazione e illustrazione e magari realizzare qualche bozzetto.
 |
| Jani Lunablau. |
 |
| Sandrine Duc. |
La seconda settimana di luglio a Sarmede faceva un gran caldo e fin dal primo giorno di corso è stato subito chiaro che avremmo sudato parecchio e non solo per l’alta temperatura.
Valeria ha cominciato considerando le poesie che ogni allievo aveva scelto e gli eventuali bozzetti fatti, così da assegnare a ognuno di noi la poesia più adatta da illustrare.
Dovevamo realizzare una o più illustrazioni per la poesia da inserire nel libro, una o anche due illustrazioni sempre legate alla poesia per la mostra itinerante che accompagnerà l’uscita del libro, un’immagine per la copertina, che sarebbe stata scelta dall’editore, proporre almeno tre titoli.
Valeria ci ha richiesto anche di scrivere il colophon. Ho così imparato che nei libri d’artista il colophon non è composto solo dai dati informativi consueti ma anche dall’indicazione della tiratura, dalla genesi del libro, dai nomi delle persone coinvolte, ed eventuali aneddoti.
Insomma il colophon diventa un piccolo, prezioso racconto di quel che è l’oggetto libro che si tiene in mano.
 |
| Anita Cerpelloni. |
 |
| Oana Alexandrescu. |
Sono rimasta affascinata dal mondo lavorativo e professionale che riguarda il libro d’artista del quale Valeria ci ha fornito utili e interessanti informazioni, relative anche al mondo dell’arte in generale.
La mole di lavoro da svolgere era tanta e non facile ma il gruppo di diciassette persone, scelte personalmente da Valeria visionando i portfolio e in base alla tecnica usata da ognuno in modo da avere una grande varietà di immagini all’interno del libro, ha dimostrato coesione e concentrazione.
Io ho riscontrato grande professionalità e capacità tra i miei compagni come raramente mi era capitato a un corso. In realtà non sembrava neanche di partecipare a un corso, ma di far parte di una fucina creativa (credo che questa parola mi sia stata suggerita dalla sensazione di caldo che ancora mi porto addosso) in cui si respirava un’aria intensa, ricca di scambio di competenze in funzione della realizzazione di un lavoro comune, di una pubblicazione.
Durante il corso il gruppo è stato anche supportato e seguito da due assistenti, Roberta Campagnolo e Antonia Conte.
 |
| Rossana Bossù. |
 |
| Laura Toro Bermejo. |
Valeria è un’insegnante di grande esperienza, molto competente e professionale, mette a disposizione dell’allievo la propria conoscenza come artista e come curatrice di mostre d’arte, ma è anche severa, quella severità che ti porta a sperimentare, non accontentarti della prima versione, ricercare, provare, sfruttare appieno il proprio modo di esprimersi senza prendere scorciatoie.
In questo caso, in cui il lavoro di ognuno doveva confluire in un progetto comune, la richiesta di professionalità era ancora più alta. L’editore Tassotti ha messo a disposizione un grafico che durante il corso ha scansionato le immagini e ha iniziato il lavoro d’impaginazione, così tutti hanno avuto la possibilità di comprendere in pratica le necessità tecniche, le problematiche e i vari passaggi in funzione del prodotto libro.
Sì perché, come ha ripetuto mille volte Paolo Canton durante i suoi corsi, anche in questo caso Valeria ha voluto sottolineare la questione: l’immagine, l’illustrazione, se in funzione di un libro, non va considerata come entità a sé ma come parte di un tutto. Se come illustratori, quando creiamo un’immagine, pensiamo a essa come a un libro che comprende il testo, la narrazione, il formato, l’impaginazione, il tipo di carta e di rilegatura, la stampa, in cui ogni elemento è legato all’altro, faremo sicuramente un lavoro migliore.
 |
| Elide Piras. |
A inizio corso Valeria ci ha detto che il plurale di Illustriamo un libro indicava proprio un lavoro di gruppo a cui anche lei avrebbe contribuito non solo con l’insegnamento e il supporto durante la creazione delle illustrazioni. Una volta terminate le immagini è iniziato il lavoro difficile di Valeria nel dare la giusta sequenza alle illustrazioni all’interno del libro, impresa non facile considerata la profonda diversità di tecnica e di realizzazione.
Qualche settimana fa abbiamo potuto vedere una bozza del libro, sfogliandolo si percepisce tutto il lavoro e l’impegno del gruppo nel realizzarlo.
Nonostante tutti i nostri sforzi ci è mancato il tempo di proporre il colophon e la copertina del libro, di quest’ultima abbiamo però avuto la possibilità di realizzare delle proposte da casa e inviarle per sottoporle alla scelta dell’editore. Ovviamente la mancanza di tempo non è stata dovuta alla nostra lentezza nel lavorare, ma al mese di luglio più caldo degli ultimi 136 anni.
 |
| Claudia Castiglioni. |