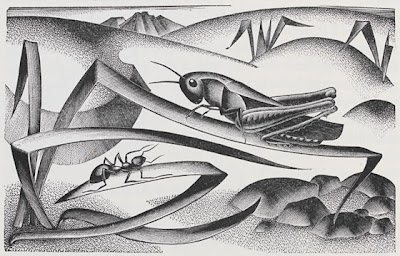Ammettiamo la nostra ignoranza: in questi giorni si festeggiavano i 40 anni di Grammatica della Fantasia, introduzione all’arte di inventare storie, e noi non lo sapevamo... Chi l'ha scritto, questo libro, lo sapete tutti: Gianni Rodari (e se non lo sapete è meglio che corriate seduta stante a colmare le vostre vistose lacune in merito ai libri per ragazzi). La Grammatica della Fantasia è stato pubblicato da Einaudi nel 1973, e a oggi
ne sono uscite sei edizioni. L’ultima, nella collana La biblioteca
di Gianni Rodari di Einaudi Ragazzi. Noi siamo stati richiamati all'ordine e alla notizia, da un articolo uscito su L'Unità, il 13 maggio scorso, firmato da Giovanni Nucci (dei cui articoli ci siamo già bellamente approfittati su questo blog) che la nostra Valentina Colombo ci ha passato, entusiasta. Un articolo che oltre a ricordare questo libro la cui conoscenza è fondamentale, e non solo per chi si occupa di bambini, afferma cose importanti sulle parole. Anzi, molto più che importanti: da scolpire nella pietra, o anche solo da scrivere in bella calligrafia su un post-it da appiccicare al frigo, ma in bella vista, così tutte le mattine, quando si accende la luce, lo si trova, e invece che a comprare uova o banane, prima si pensa alle parole. Giovanni ci ha permesso di pubblicarlo e noi lo ringraziamo molto, per questo.
Scriveva Tullio De Mauro, nel 1974, riguardo alla Grammatica della Fantasia: «Come Cimarosa col suo Maestro di Cappella, come Rilke nelle Lettere ad un giovane poeta, come Goethe e Leopardi in certe loro pagine, un’artista ha messo in tavola le carte del suo gioco. E ne è nato, elegante e geniale, un classico». Quello che sembra suggerirci è che questo libretto vada oltre il suo oggetto, la contingenza del suo tempo, del suo scopo dichiarato, dei suoi primi ed immediati lettori. Su queste pagine potremo, in effetti, scrivere di Rodari una volta al mese, quindi praticamente una su due, il che è abbastanza imbarazzante: Rodari ha pubblicato circa cinquanta libri, si andrebbe avanti per quasi quattro anni, dopo di che si potrebbe ricominciare da capo trovando ogni volta una nuova meraviglia in quei libri, un motivo di incalzante attualità per poterne parlarne. Diventerebbe, così, la rubrica di un solo autore, condotta da un critico che legge e rilegge sempre gli stessi cinquanta libri. Sarebbe, in effetti, meraviglioso: tanto da assomigliare ad un racconto di Borges o (peggio, molto peggio!) di Gianni Rodari.
Ora, per quanto possiamo tranquillamente considerare i racconti e le poesie, e le filastrocche di Rodari universali, impermeabili al tempo e alla geografia, non dovrebbe essere altrettanto facile farlo per la Grammatica della fantasia che però (com’è, come non è), uscita giusto quarant’anni fa, sta lì imperterrita e ancora oggi ispira e aiuta gli scrittori e i poeti per ragazzi, così come gli accademici, i critici, i giornalisti, gli insegnanti, i librai, i promotori della lettura, i bibliotecari, gli editori, gli animatori, i maestri e i genitori. Già loro (si potrebbe dire) fanno una buona fetta della popolazione utile e intellettualmente attiva, ma (si potrebbe obiettare) cosa dovrebbe interessare questo libro a un sottosegretario, al capitano di un bastimento, a un vigile urbano (a parte l’evidente motivo d’essere essi stessi molto probabilmente protagonisti d’una buona cifra di altri libri di Rodari)?
Per rispondere, prendiamo volentieri in prestito delle righe a riguardo di Marzia Corraini: «Mi limito, ed è assolutamente sufficiente, a osservare l’importanza di questo titolo […] C’è una grammatica della fantasia. Ci sono regole o semplici modalità e stimoli per indicare una via. C’è la fantasia e la grande capacità di inventare partendo dal noto. E proprio qui sta la grandezza di Rodari, nel fa vedere come “usare la testa” liberamente per procedere verso la conoscenza attraverso piccoli progressi, prima sulla strada tracciata, poi tresgredendo, mettendo assieme opposti e lontani, immaginando sintesi e soluzioni non previste. Rodari certo, e con lui Munari e anche Alighiero Boetti, Toti Scialoja. Geniali autori e pensatori che ci hanno insegnato […] che esiste anche una modalità da proporre, da segnalare, da indicare perché ognuno di noi possa utilizzare con originalità la propria fantasia o meglio il proprio “pensiero”».
C’è, per tornare a De Mauro, un valore assoluto dell’arte, che non è detto siamo capaci di cogliere, e che va al di là del valore che presupponiamo di poterle attribuire. A volte quel valore si trasferisce alle opere che ne parlano, dell’arte. Volendolo cercare di esplicitarlo relativamente alla Grammatica della Fantasia di Rodari, citiamo ciò che ne dice lui stesso: «Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possano avere la parole. “Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo». Ed ecco che l’attualità del suo pensiero, del Rodari filosofo che in questo libro si esprime al meglio, viene subito fuori: non dobbiamo scordarci, oggi più che mai, il valore di liberazione che può avere la parola: proprio quando la libertà sulle parole sembrerebbe essere assoluta, e le sta invece sempre di più impoverendo di potere e di importanza. Perché se le parole sono strumento di liberazione, occorre salvaguardarle con la massima attenzione. «Tutte le parole a tutti quanti». Quindi.
Scriveva Tullio De Mauro, nel 1974, riguardo alla Grammatica della Fantasia: «Come Cimarosa col suo Maestro di Cappella, come Rilke nelle Lettere ad un giovane poeta, come Goethe e Leopardi in certe loro pagine, un’artista ha messo in tavola le carte del suo gioco. E ne è nato, elegante e geniale, un classico». Quello che sembra suggerirci è che questo libretto vada oltre il suo oggetto, la contingenza del suo tempo, del suo scopo dichiarato, dei suoi primi ed immediati lettori. Su queste pagine potremo, in effetti, scrivere di Rodari una volta al mese, quindi praticamente una su due, il che è abbastanza imbarazzante: Rodari ha pubblicato circa cinquanta libri, si andrebbe avanti per quasi quattro anni, dopo di che si potrebbe ricominciare da capo trovando ogni volta una nuova meraviglia in quei libri, un motivo di incalzante attualità per poterne parlarne. Diventerebbe, così, la rubrica di un solo autore, condotta da un critico che legge e rilegge sempre gli stessi cinquanta libri. Sarebbe, in effetti, meraviglioso: tanto da assomigliare ad un racconto di Borges o (peggio, molto peggio!) di Gianni Rodari.
Ora, per quanto possiamo tranquillamente considerare i racconti e le poesie, e le filastrocche di Rodari universali, impermeabili al tempo e alla geografia, non dovrebbe essere altrettanto facile farlo per la Grammatica della fantasia che però (com’è, come non è), uscita giusto quarant’anni fa, sta lì imperterrita e ancora oggi ispira e aiuta gli scrittori e i poeti per ragazzi, così come gli accademici, i critici, i giornalisti, gli insegnanti, i librai, i promotori della lettura, i bibliotecari, gli editori, gli animatori, i maestri e i genitori. Già loro (si potrebbe dire) fanno una buona fetta della popolazione utile e intellettualmente attiva, ma (si potrebbe obiettare) cosa dovrebbe interessare questo libro a un sottosegretario, al capitano di un bastimento, a un vigile urbano (a parte l’evidente motivo d’essere essi stessi molto probabilmente protagonisti d’una buona cifra di altri libri di Rodari)?
Per rispondere, prendiamo volentieri in prestito delle righe a riguardo di Marzia Corraini: «Mi limito, ed è assolutamente sufficiente, a osservare l’importanza di questo titolo […] C’è una grammatica della fantasia. Ci sono regole o semplici modalità e stimoli per indicare una via. C’è la fantasia e la grande capacità di inventare partendo dal noto. E proprio qui sta la grandezza di Rodari, nel fa vedere come “usare la testa” liberamente per procedere verso la conoscenza attraverso piccoli progressi, prima sulla strada tracciata, poi tresgredendo, mettendo assieme opposti e lontani, immaginando sintesi e soluzioni non previste. Rodari certo, e con lui Munari e anche Alighiero Boetti, Toti Scialoja. Geniali autori e pensatori che ci hanno insegnato […] che esiste anche una modalità da proporre, da segnalare, da indicare perché ognuno di noi possa utilizzare con originalità la propria fantasia o meglio il proprio “pensiero”».
C’è, per tornare a De Mauro, un valore assoluto dell’arte, che non è detto siamo capaci di cogliere, e che va al di là del valore che presupponiamo di poterle attribuire. A volte quel valore si trasferisce alle opere che ne parlano, dell’arte. Volendolo cercare di esplicitarlo relativamente alla Grammatica della Fantasia di Rodari, citiamo ciò che ne dice lui stesso: «Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possano avere la parole. “Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo». Ed ecco che l’attualità del suo pensiero, del Rodari filosofo che in questo libro si esprime al meglio, viene subito fuori: non dobbiamo scordarci, oggi più che mai, il valore di liberazione che può avere la parola: proprio quando la libertà sulle parole sembrerebbe essere assoluta, e le sta invece sempre di più impoverendo di potere e di importanza. Perché se le parole sono strumento di liberazione, occorre salvaguardarle con la massima attenzione. «Tutte le parole a tutti quanti». Quindi.