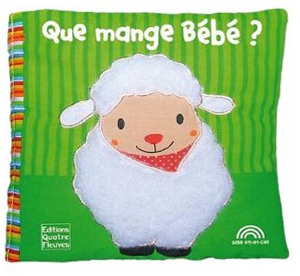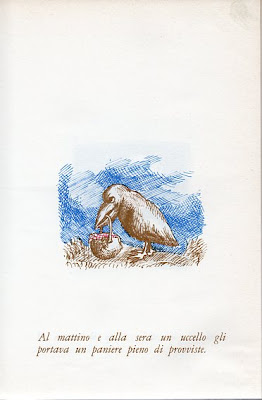|
| Questa sono io. La foto è di Fabrice Beau. |
[di Francesca Ferri]
Mi chiamo Francesca Ferri e illustro libri di stoffa per bambini piccolissimi.
Il mio mestiere, nella sua estrema specializzazione, suscita sempre molta curiosità.
Qualche settimana fa, al pranzo per celebrare
Cicale, il primo libro di
Marta Iorio, ho finalmente incontrato di persona Paolo Canton della casa editrice Topipittori e Anna Castagnoli curatrice del blog
Le figure dei libri. In quella occasione, entrambi mi hanno chiesto di raccontare il percorso che mi ha portato a fare questo lavoro. Si sono accapigliati un po' e, dopo qualche giorno, mi hanno informato di essersi accordati: il post sarebbe uscito - se avevo veramente intenzione di farlo - sul blog dei Topi. Ed eccomi qua. Ignoro che cosa Anna abbia ottenuto in cambio
Ho studiato arte sperimentando grafica, pittura e arte concettuale, appassionandomi di quell'arte moderna che cerca di unire nell'opera linguaggi diversi, e mira a coinvolgere altri sensi oltre la vista.
Ho sempre cercato di giocare e divertirmi creando le mie opere e spesso il giudizio generale che ricevevo era che il mio linguaggio sembrava indirizzato a un pubblico infantile, anche se in realtà non ne avevo avuto l'intenzione.
Finiti gli studi ho fatto diversi lavori nel campo delle arti visive. Poi io e Oscar, il mio fidanzato, che fa il grafico, abbiamo aperto un piccolo studio e l'abbiamo chiamato
Pirulino.
 |
| Questo è lo studio Pirulino visto da fuori... |
Una delle prime commesse furono le illustrazioni di un libro di archeologia per bambini, al quale lavorammo insieme a Pietro Grandi, talentuoso fumettista.
Presentammo le illustrazioni realizzate al concorso per la
Mostra degli Illustratori della
Bologna Children's Book Fair e le tavole vennero selezionate.
Bisognava quindi sfruttare l'occasione per presentarsi agli editori in fiera. Mi resi conto che i miei lavori di illustrazione erano pochi per costituire un vero portfolio, cercai quindi di farmi venire qualche idea.
 |
| ... e dentro |
La mia vita quotidiana in quel periodo era dedicata ai figli, piccolissimi, e al mio lavoro. Non avevo tempo di leggere neanche una riga di un libro o di vedere un film, per cui presi ispirazione da ciò che avevo intorno per inventare un libro di stoffa che cucii io stessa (credo non ci fosse neanche una cucitura diritta), composto da scenari semi-astratti e corredato da animaletti sagomati con cui i bambini potevano giocare liberamente sulle pagine.
Feci un test all'asilo nido, le "dade" dei miei figli e i bambini erano entusiasti, facevano i turni per giocarci: il libro piaceva e funzionava.
A questo punto dovevo presentarlo, ma come? Avevo visitato molte volte la fiera, ma non conoscevo il mondo dell'editoria, non sapevo come prendere contatti e nemmeno cosa dire per presentare il libro.
 |
| Alla fiera di Hong Kong. |
Mi piacevano molto gli albi illustrati di
Chiara Rapaccini, così Oscar mi suggerì di chiamarla e chiedere consiglio a lei. Mi invitò nel suo studio a Roma: Chiara fu generosissima e mi spiegò l'ABC di rapporti e trattative con gli editori. Apprezzò anche alcuni disegni a tratto molto grafico, quindi decisi di prepararne una serie da presentare in fiera. Credo che, al di là delle nozioni pratiche, Chiara Rapaccini mi abbia dato una grande spinta, mi abbia convinto a lanciarmi.
Giunta in fiera mi presentai agli editori che avevo selezionato, ricevetti tantissimi responsi negativi. Poi trovai due stand che esponevano esclusivamente libri di stoffa. Uno in particolare,
Rettore, era minuscolo. I due ragazzi che mi ricevettero mi dissero subito che non era possibile produrre il libro in serie, perché i costi sarebbero stati troppo alti, ma si mostrarono interessati all'idea e al mio stile grafico.
 |
| Una delle fabbriche dove si producono i miei libri. |
Non era proprio una casa editrice. Era un "packager": un'azienda che crea progetti di libri, li propone agli editori e li produce. Scoprii in seguito che questi due ragazzi avevano aperto la loro attività da pochi mesi e cercavano qualcuno che gli curasse sia il design del prodotto sia le illustrazioni.
Cominciai così a collaborare con loro: mi commissionarono le illustrazioni per un primo libro che fu un banco di prova per entrambi.
Come spesso capita alla prima esperienza sbagliai un poco la scelta dei colori e l'impostazione della copertina non era risolta bene, ma feci di tutto per presentare un progetto tecnicamente perfetto e nei tempi indicati. Anche il committente fu puntuale nei pagamenti e questo creò la base del nostro rapporto.
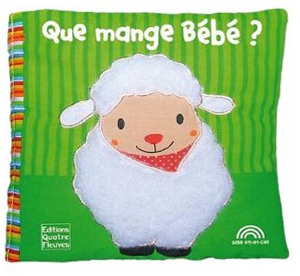 |
| Da undici anni faccio libri così... |
Durante la lavorazione di questo primo libro nacque un forte scambio di idee su quali, come e quanti libri di stoffa avremmo potuto fare. Cominciai a stilare un elenco e lo aggiornavo continuamente.
A un certo punto mi resi conto che erano decine di titoli e con un po' d'ansia chiesi: «Ma quand'è che li dobbiamo fare?» La risposta fu tranquillizzante: «Nei prossimi anni!» E così è stato. Ed è così che sono diventata una fabbrica di illustrazioni.
 |
| ... e così... |
In questi 11 anni, ho disegnato circa duecento libri. Gran parte di questo tempo l'ho trascorsa dentro il mio studio, disegnando. Il lavoro a distanza può risultare un po' alienante, anche per una persona solitaria come me. Per compensare ho voluto conoscere approfonditamente tutto il percorso che un'idea compie per trasformarsi in libro e finire in mano a un bambino: ho visitato le fabbriche manifatturiere in Cina; ho incontrato alle fiere agenti, produttori ed editori di tutto il mondo; e ho condotto laboratori per costruire libri di stoffa con i bambini.
Amo il confronto con i bambini in età prescolare, mi regalano sempre punti di vista inaspettati sul libro.
Amo anche andare alle fiere: parlare con persone provenienti da paesi e culture che mai avrei la possibilità di conoscere, è un confronto stimolante.
 |
| ... e così. |
Tra tutti gli incontri mi piace ricordare un signore armeno, intellettuale poverissimo, che tutti gli anni viene allo stand Rettore durante la Buchmesse di Francoforte, entusiasta dei nostri libri e che ogni volta, fissandomi con i suoi grandi occhi azzurri che sembrano finiti per sbaglio nel volto scuro e barbuto, mi dice: «Ce la farò, sono sicuro che ce la farò a portare questi libri nel mio paese!» e io ogni volta gli rispondo di sì, anche se entrambi sappiamo che nessun bambino armeno potrebbe permettersi di comprare neanche una pagina di un libro di stoffa...
 |
| Un po' dei miei doudou sullo scaffale, pronti per essere adottati. |
Alla fine di tutto il processo, il libro finisce nelle mani di un bebè, che lo studia, lo scuote, lo stropiccia, lo ciuccia e lo usa per sperimentare e conoscere se stesso.
Il mio augurio è che ogni libro possa essere per un bambino e per chi gli sta accanto un'occasione per scoprire insieme la meraviglia delle cose che accadono per la prima volta.
E che un giorno questo possa succedere anche in Armenia. In fondo, è già successo più o meno un milione e mezzo di volte, in ogni angolo del mondo. Perché nel preparare questo post ho fatto un po' di conti e ho scoperto, non senza sorpresa, che i miei duecento libri sono stati venduti in tutto il mondo in un milione e mezzo di copie (in totale, non ciascuno).
 |
Prendete questo bambino e moltiplicatelo per un milione e mezzo.
Impressionante, vero? |
Sotto la rubrica "Avventure" trovate anche questi post: