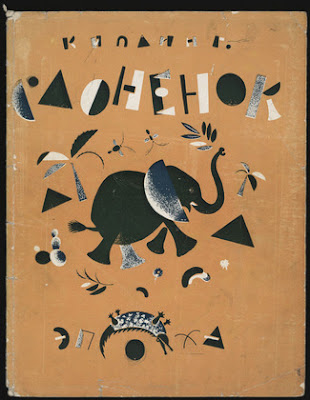Oggi, nei paesi di cultura anglosassone è Halloween. Anziché mettere sul davanzale una innocua zucca di plastica comprata al supermercato, vi proponiamo di festeggiare questa affascinante ricorrenza non nostra, in modo un po' più terrifico, in compagnia del massimo esperto di letteratura e materiali horror del mondo: sua maestà Stephen King. Sotto i cui panni da autore ipercommerciale da megastore, (lo sa bene Antonio Faeti che gli ha dedicato un bellissimo saggio, La casa sull'albero), si cela un grande, grandissimo scrittore. E anche un colto, coltissimo conoscitore dell'animo umano e della letteratura che nei suoi più riposti meandri si inabissa. Come mostra Danse macabre, (io ho la prima edizione integrale edita in Italia, quella di Theoria del 1992; oggi è in commercio l'edizione Sperling), sterminato catalogo dell'horror in cinema, fumetto, letteratura, ma soprattutto fine esegesi dell'angoscia, della paura, della scrittura nera, dei lettori che amano incubi e terrore e della fascinazione che il mondo dell'Ombra da sempre esercita su bambini e ragazzi. Che non per nulla sono fra i prediletti protagonisti di alcune fra le sue più celebri storie. Ve ne proponiamo alcuni brani. Spegnete la luce. E buona lettura.
Quando Coleridge parlò di «sospensione dell'incredulità» nel suo saggio sulla poesia di immaginazione, penso sapesse che che l'incredulità non è come un pallone, che può essere sospeso in aria con uno sforzo minimo; è come un peso di piombo, e dev'essere alzato e tenuto su con la forza.
[...] E quando incontro qualcuno che dice: «Non leggo fantasy né vado a vedere quei film, non c'è niente di vero», sento una certa simpatia. Non riescono a sollevare il peso della fantasia. I muscoli della loro immaginazione sono troppo deboli.
In questo senso i bambini sono il pubblico perfetto per l'horror. Questo è il paradosso: i bambini, molto deboli fisicamente, sollevano con facilità il peso dello scetticismo. Sono i prestigiatori dell'invisibile, un fenomeno perfettamente comprensibile quando e se si considera la prospettiva dalla quale vedono le cose. I bambini manipolano abilmente la logistica dell'entrare nelle case di Babbo Natale (passa dai camini perché si fa piccolo piccolo, e se non c'è il camino c'è la buca delle lettere, e se non c'è la buca delle lettere c'è sempre lo spazio sotto la porta), il Coniglio Pasquale, Dio (un omone un po' vecchio, grande barba bianca, un trono), Gesù [...], il diavolo, Ronald McDonald, il Re degli Hamburger, il Ranger Solitario, e altri mille.
La maggioranza dei genitori crede di capire questa apertura mentale meglio di quanto, in molti, casi, capiscano davvero, e cercano di evitare che i bambini vedano qualcosa che puzzi troppo di orrore e terrore. [...] Ma uno degli strani effetti Doppler che sembrano accadere durante il selettivo dimenticare che è parte integrante del crescere, è il fatto che praticamente tutto ha il potenziale di impaurire i bambini sotto gli otto anni. In certi momenti e in certi posti i bambini hanno letteralmente paura delle loro ombre. [...]
Visti in questa luce, anche i film Disney sono campi minati di terrore, e i cartoni animati che verranno a quanto pare programmati e riprogrammati fino alla fine del mondo, sono di solito i peggiori esempi. Esistono adulti che, se gli viene chiesto quale sia la cosa più terribile vista al cinema da bambini, risponderanno il momento in cui la mamma di Bambi è uccisa dal cacciatore, o in cui Bambi e suo padre scappano per fuggire all'incendio.
Altri ricordi disneyani che fanno il pari con l'orrore batraciforme che abita la laguna nera includono le scope che marciano impazzite in Fantasia [...] ; la notte sul Monte Calvo nello stesso film; le streghe di Biancaneve e della Bella addormentata nel bosco, una con la rossa mela avvelenata (e a quale bambino non viene insegnato subito il concetto di VELENO?), l'altra con il filatoio mortale; fino alla Carica dei 101, relativamemente innocuo, che pure presenta la logica nipotina delle streghe Disney degli anni Trenta e Quaranta, la Malvagia Crudelia Demon, con la sua magra, perfida faccia, la sua voce potente (gli adulti a volte dimenticano quanta paura facciano le voci forti ai bambini, anche perché vengono da giganti del loro mondo, gli adulti), e il suo piano di uccidere tutti i cuccioli di dalmata (leggi «bambini», se si è piccoli) e farne pellicce.
Eppure sono i genitori ovviamente che continuano a sottoscrivere l'abitudine della Disney di riprogrammare quei film, scoprendosi addosso la pelle d'oca quando si ricordano di quel che li impauriva da bambini... perché ciò che fa un buon film dell'orrore [...] è togliere i nostri puntelli da adulti e farci scivolare per la discesa verso l'infanzia. E lì la nostra ombra può diventare ancora una volta quella di un cane cattivo, una bocca spalancata, o una figura scura che ci chiama. [...]
L'ironia di tutto questo è che i bambini riescono a trattare con il fantastico e l'orrore alle sue condizioni molto meglio degli adulti. Noterete che ho usato il corsivo per le parole “alle sue condizioni». Un adulto accetta il cataclismico terrore di Non aprite quella porta perché lui o lei sanno che è solo una finta, che quando la scena è girata i morti si alzeranno e si laveranno via il sangue finto. Il bambino non riesce a fare queste distinzioni e il film è giustamente vietato. I bambini non hanno bisogno di vedere quelle scene [...]. Ma il punto è: se si mette un bambino di sei anni a vedere una proiezione di Non aprite quella porta insieme a un adulto reso temporaneamente incapace di distinguere fra finzione e «le cose vere» (come dice Danny Torrance, il bambino di Shining) [...], io dico che il bambino avrà incubi per una settimana. L'adulto sarebbe internato per un anno in una stanza imbottita, e scriverebbe a casa con i pastelli a cera.
Nella vita di un bambino una certa dose di fantasy e di orrore mi sembra una cosa perfettamente a posto, anche utile. Per la loro capcità di immaginare, i bambini riescono a conviverci, e per la loro posizione unica nella vita, sono capaci di usare certi sentimenti. E capiscono anche molto bene la loro posizione. Persino in una società relativamente ordinata come la nostra, capiscono che la loro sopravvivenza è totalmente al di fuori del loro controllo. I bambini sono «dipendenti» fino all'età di otto anni in ogni senso della parola. Dipendenti dal padre e dalla madre (o di un ragionevole facsimile) non solo per il cibo, i vestiti e una casa; dipendono da loro per non sbattere con la macchina contro un pilone del ponte, per essere portati allo scuolabus in tempo, per essere riaccompagnati a casa dopo essere stati dagli scout, perché comprino medicinali con tappi a prova di bambino; dipendono dagli adulti anche per non prendere la scossa con il tostapane o cercando di giocare con la il Salone di Bellezza di Barbie nella vasca da bagno.
La direttiva di sopravvivenza dentro di noi ci invita a lottare contro questa necessaria dipendenza. Il bambino si accorge della sua essenziale mancanza di controllo, e sospetto che sia questa scoperta a metterlo a disagio. È la stessa ansietà aleggiante che provano molti viaggiatori in aereo. Non hanno paura perché pensano che l'aereo non sia sicuro; hanno paura perché hanno ceduto il controllo, e se qualcosa va storto possono solo stare lì seduti a tormentare la rivista della compagnia aerea o i sacchetti per vomitare. Cedere il controllo è contrario alla direttiva di sopravvivenza. [...]
Questa nascosta ansietà e ostilità verso i piloti delle loro vite può essere una delle spiegazioni per cui, come i film Disney che escono in perpetuo ogni Natale, anche le vecchie favole sembrano andare avanti per sempre. Un genitore che alzerebbe le mani terrificato al pensiero di portare i bambini a vedere Dracula [...] certo non obietterebbe se la bambinaia gli leggesse Hansel e Gretel prima di metterli a letto. Ma considerate: la favola di Hansel e Gretel comincia con un volontario abbandono [...], continua con un rapimento [...], con la schiavitù, con un'illegale detenzione, e alla fine con un giustificabile omicidio e cremazione.
Anche gli ansiosi viaggiatori di aereo hanno le loro favole, i film dell'interminabile serie Airport, che come Hansel e Gretel e i cartoni della Disney mostrano ogni segno di poter andare avanti per sempre...
Quando Coleridge parlò di «sospensione dell'incredulità» nel suo saggio sulla poesia di immaginazione, penso sapesse che che l'incredulità non è come un pallone, che può essere sospeso in aria con uno sforzo minimo; è come un peso di piombo, e dev'essere alzato e tenuto su con la forza.
[...] E quando incontro qualcuno che dice: «Non leggo fantasy né vado a vedere quei film, non c'è niente di vero», sento una certa simpatia. Non riescono a sollevare il peso della fantasia. I muscoli della loro immaginazione sono troppo deboli.
In questo senso i bambini sono il pubblico perfetto per l'horror. Questo è il paradosso: i bambini, molto deboli fisicamente, sollevano con facilità il peso dello scetticismo. Sono i prestigiatori dell'invisibile, un fenomeno perfettamente comprensibile quando e se si considera la prospettiva dalla quale vedono le cose. I bambini manipolano abilmente la logistica dell'entrare nelle case di Babbo Natale (passa dai camini perché si fa piccolo piccolo, e se non c'è il camino c'è la buca delle lettere, e se non c'è la buca delle lettere c'è sempre lo spazio sotto la porta), il Coniglio Pasquale, Dio (un omone un po' vecchio, grande barba bianca, un trono), Gesù [...], il diavolo, Ronald McDonald, il Re degli Hamburger, il Ranger Solitario, e altri mille.
La maggioranza dei genitori crede di capire questa apertura mentale meglio di quanto, in molti, casi, capiscano davvero, e cercano di evitare che i bambini vedano qualcosa che puzzi troppo di orrore e terrore. [...] Ma uno degli strani effetti Doppler che sembrano accadere durante il selettivo dimenticare che è parte integrante del crescere, è il fatto che praticamente tutto ha il potenziale di impaurire i bambini sotto gli otto anni. In certi momenti e in certi posti i bambini hanno letteralmente paura delle loro ombre. [...]
Visti in questa luce, anche i film Disney sono campi minati di terrore, e i cartoni animati che verranno a quanto pare programmati e riprogrammati fino alla fine del mondo, sono di solito i peggiori esempi. Esistono adulti che, se gli viene chiesto quale sia la cosa più terribile vista al cinema da bambini, risponderanno il momento in cui la mamma di Bambi è uccisa dal cacciatore, o in cui Bambi e suo padre scappano per fuggire all'incendio.
Altri ricordi disneyani che fanno il pari con l'orrore batraciforme che abita la laguna nera includono le scope che marciano impazzite in Fantasia [...] ; la notte sul Monte Calvo nello stesso film; le streghe di Biancaneve e della Bella addormentata nel bosco, una con la rossa mela avvelenata (e a quale bambino non viene insegnato subito il concetto di VELENO?), l'altra con il filatoio mortale; fino alla Carica dei 101, relativamemente innocuo, che pure presenta la logica nipotina delle streghe Disney degli anni Trenta e Quaranta, la Malvagia Crudelia Demon, con la sua magra, perfida faccia, la sua voce potente (gli adulti a volte dimenticano quanta paura facciano le voci forti ai bambini, anche perché vengono da giganti del loro mondo, gli adulti), e il suo piano di uccidere tutti i cuccioli di dalmata (leggi «bambini», se si è piccoli) e farne pellicce.
Eppure sono i genitori ovviamente che continuano a sottoscrivere l'abitudine della Disney di riprogrammare quei film, scoprendosi addosso la pelle d'oca quando si ricordano di quel che li impauriva da bambini... perché ciò che fa un buon film dell'orrore [...] è togliere i nostri puntelli da adulti e farci scivolare per la discesa verso l'infanzia. E lì la nostra ombra può diventare ancora una volta quella di un cane cattivo, una bocca spalancata, o una figura scura che ci chiama. [...]
L'ironia di tutto questo è che i bambini riescono a trattare con il fantastico e l'orrore alle sue condizioni molto meglio degli adulti. Noterete che ho usato il corsivo per le parole “alle sue condizioni». Un adulto accetta il cataclismico terrore di Non aprite quella porta perché lui o lei sanno che è solo una finta, che quando la scena è girata i morti si alzeranno e si laveranno via il sangue finto. Il bambino non riesce a fare queste distinzioni e il film è giustamente vietato. I bambini non hanno bisogno di vedere quelle scene [...]. Ma il punto è: se si mette un bambino di sei anni a vedere una proiezione di Non aprite quella porta insieme a un adulto reso temporaneamente incapace di distinguere fra finzione e «le cose vere» (come dice Danny Torrance, il bambino di Shining) [...], io dico che il bambino avrà incubi per una settimana. L'adulto sarebbe internato per un anno in una stanza imbottita, e scriverebbe a casa con i pastelli a cera.
Nella vita di un bambino una certa dose di fantasy e di orrore mi sembra una cosa perfettamente a posto, anche utile. Per la loro capcità di immaginare, i bambini riescono a conviverci, e per la loro posizione unica nella vita, sono capaci di usare certi sentimenti. E capiscono anche molto bene la loro posizione. Persino in una società relativamente ordinata come la nostra, capiscono che la loro sopravvivenza è totalmente al di fuori del loro controllo. I bambini sono «dipendenti» fino all'età di otto anni in ogni senso della parola. Dipendenti dal padre e dalla madre (o di un ragionevole facsimile) non solo per il cibo, i vestiti e una casa; dipendono da loro per non sbattere con la macchina contro un pilone del ponte, per essere portati allo scuolabus in tempo, per essere riaccompagnati a casa dopo essere stati dagli scout, perché comprino medicinali con tappi a prova di bambino; dipendono dagli adulti anche per non prendere la scossa con il tostapane o cercando di giocare con la il Salone di Bellezza di Barbie nella vasca da bagno.
La direttiva di sopravvivenza dentro di noi ci invita a lottare contro questa necessaria dipendenza. Il bambino si accorge della sua essenziale mancanza di controllo, e sospetto che sia questa scoperta a metterlo a disagio. È la stessa ansietà aleggiante che provano molti viaggiatori in aereo. Non hanno paura perché pensano che l'aereo non sia sicuro; hanno paura perché hanno ceduto il controllo, e se qualcosa va storto possono solo stare lì seduti a tormentare la rivista della compagnia aerea o i sacchetti per vomitare. Cedere il controllo è contrario alla direttiva di sopravvivenza. [...]
Questa nascosta ansietà e ostilità verso i piloti delle loro vite può essere una delle spiegazioni per cui, come i film Disney che escono in perpetuo ogni Natale, anche le vecchie favole sembrano andare avanti per sempre. Un genitore che alzerebbe le mani terrificato al pensiero di portare i bambini a vedere Dracula [...] certo non obietterebbe se la bambinaia gli leggesse Hansel e Gretel prima di metterli a letto. Ma considerate: la favola di Hansel e Gretel comincia con un volontario abbandono [...], continua con un rapimento [...], con la schiavitù, con un'illegale detenzione, e alla fine con un giustificabile omicidio e cremazione.
Anche gli ansiosi viaggiatori di aereo hanno le loro favole, i film dell'interminabile serie Airport, che come Hansel e Gretel e i cartoni della Disney mostrano ogni segno di poter andare avanti per sempre...