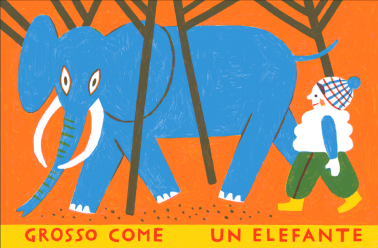[di Susanna Mattiangeli]
Vi è mai capitato di parlare con dei gruppi di genitori? A me sì, tanto, negli ultimi anni mi è capitato di parlare con molti genitori. A voce, per telefono, per email, su whatsapp. Ho raccolto centinaia di dubbi, incertezze e false convinzioni. Quindi ho pensato che c'è bisogno di chiarezza e, siccome ho avuto a che fare con qualche bambino e soprattutto ho un computer, credo di avere tutti i titoli per dire la mia sul tema della genitoliarità. Genitolarità. Genitorialità. Insomma su quella cosa di quando sei un genitore. Allora sono andata in giro per librerie, parchi, negozi e in una mattinata ho tirato fuori un agile pamphlet in cui ognuno può trovare la sua risposta. Eccolo qui:
Manuale universale per genitori
I genitori migliori sono quelli che erano già genitori migliori da prima. Sono quelli che si erano già iscritti ai corsi, avevano già letto i manuali, avevano già comprato tutto. Sono quelli che quando ci sono loro, si parla sempre di essere genitori.
Non è vero, diventare genitori è un fatto naturale, non serve prepararsi, basta lasciar succedere le cose e tutto andrà come deve andare. I genitori migliori fanno finta di niente e non hanno bisogno di libri. Giusto una sbirciatina, magari, se le cose si mettono male.
Macché. I genitori migliori, si sa, sono i Francesi.
Si vede che non avete le basi. I genitori migliori sono gli Arapesh della nuova Guinea.
Oggi però i genitori migliori tengono un diario, scrivono un libro, fanno un film, un disco, una mostra per condividere tutti i loro dubbi, le loro emozioni e le cose simpaticissime che succedono loro ogni giorno.
E però basta con questi figli esposti come opere d’arte, non se ne può più di foto, di pensierini, di racconti quotidiani. Per essere dei genitori come si deve, non bisognerebbe parlare dei propri figli. Mai, neanche con loro. Se chiedono qualcosa, tagliare corto e negare tutto. Ma se proprio si deve parlare, dare almeno nomi falsi.
E l'alimentazione?
I neonati devono mangiare solo nelle ore stabilite dal medico di famiglia. Assolutamente no. I neonati devono mangiare continuamente e strillare molto forte quando vanno dal medico di famiglia. I bambini devono mangiare biologico.
No, è tutta una bufala, i bambini devono mangiare roba presa a caso tra quella che costa meno al supermercato.
I bambini vanno nutriti con i vasetti comprati in farmacia. No, i vasetti fanno male ai bambini. Nessuno dovrebbe mangiare vasetti in generale.
Ai figli bisogna dare farina di semi di miglio cotta al vapore.
Ai figli bisogna dare la Nutella.
(Comunque io ve lo dico, mi dispiace per voi ma le cose migliori da far mangiare ai bambini sono quelle che fa mia nonna e basta.)
Apprendimento
I giochi dei bambini devono essere approvati dagli esperti.
Non bisogna dare giocattoli ai bambini, ma lasciare che raccolgano nidi, pergamene, barbabietole e fossili trovati per caso mentre scorrazzano liberi nell'aia.
I genitori migliori giocano con i loro bambini, ma a fine giornata li raccolgono e li mettono a posto.
I bambini possono leggere e scrivere a tre anni.
I bambini non devono assolutamente leggere e scrivere prima dei sette anni.
I bambini devono giocare qualche ora al giorno con il tablet altrimenti non saranno competitivi nel mondo del lavoro.
Non si deve far sapere ai bambini che esistono il computer e la televisione. Se a un certo punto chiedono qualcosa, bisogna dire che non se ne sa niente. Se dovessero insistere si risponde : «Mi dispiace, non riesco a sentirti.»
I genitori migliori sono quelli che leggono ad alta voce.
Ancora migliori sono quelli che leggono ad alta voce quando c’è almeno qualcuno vicino.
Le bambine sono più tranquille dei bambini e leggono prima.
Alle bambine tutti dicono di stare tranquille e allora loro leggono prima perché altrimenti si annoiano.
Le bambine leggono prima dei bambini perché sono più veloci a prendere i libri dagli scaffali e quindi i bambini si agitano perché non hanno nient’altro da fare.
Consigli utili
Ai bambini basta dare poco.
Ai bambini bisogna dare molto.
Bisogna che i bambini si annoino.
Bisogna stimolarli.
L’importante è che si divertano.
L’importante è che si impegnino.
L’importante è seguirli sempre.
L’importante è lasciarli fare.
Bisogna saper dire no. Bisogna saper dire scusami. Bisogna saper dire "Vuoi quei kiwi?".
Quello che conta è l’esempio.
Quello che conta è il dialogo.
Bisogna ascoltarli.
Non devono stare al centro dell’attenzione.
Possono stare al centro, basta che si riesca a vedere il film.
Il bambino non va messo in imbarazzo.
Il bambino non va messo su un piedistallo.
Bisogna scendere al livello del bambino.
Bisogna innalzarsi al livello del bambino.
Bisogna che il bambino si muova.
Bisogna che sappia stare fermo, soprattutto quando è su un piedistallo.
Se i bambini stanno fermi, la terra gira intorno a loro.
Se i bambini girano insieme alla terra, alla fine del giro vogliono fare colazione.
Dopo tanti giri e tante colazioni succede che i bambini un giorno si svegliano e sono grandi. E a quel punto quello che è fatto è fatto.
Riassumendo
I genitori migliori sono quelli che non sanno di esserlo.
No, sono quelli che sanno di esserlo, ma lasciano che siano gli altri a giudicare.
I genitori migliori sono quelli che pensano di essere così così ma non sono sicuri.
No, sono quelli che pensano di essere i peggiori ma poi parlando con altri genitori cambiano idea.
I genitori migliori sono quelli che trovano tempo per se stessi.
I genitori migliori sono quelli che trovano parcheggio.
I genitori migliori sono quelli che quando leggono i manuali dicono ‘aspetta, nell’altro manuale dicevano il contrario’ e allora ne cercano un terzo, un quarto, poi passano a un romanzo, si mettono a chiacchierare e alla fine vanno a letto troppo tardi sapendo che sono rimaste pochissime ore di sonno e pensano: «Vabbè, qualcosa la so. Improvviserò.»
Vi è mai capitato di parlare con dei gruppi di genitori? A me sì, tanto, negli ultimi anni mi è capitato di parlare con molti genitori. A voce, per telefono, per email, su whatsapp. Ho raccolto centinaia di dubbi, incertezze e false convinzioni. Quindi ho pensato che c'è bisogno di chiarezza e, siccome ho avuto a che fare con qualche bambino e soprattutto ho un computer, credo di avere tutti i titoli per dire la mia sul tema della genitoliarità. Genitolarità. Genitorialità. Insomma su quella cosa di quando sei un genitore. Allora sono andata in giro per librerie, parchi, negozi e in una mattinata ho tirato fuori un agile pamphlet in cui ognuno può trovare la sua risposta. Eccolo qui:
Manuale universale per genitori
I genitori migliori sono quelli che erano già genitori migliori da prima. Sono quelli che si erano già iscritti ai corsi, avevano già letto i manuali, avevano già comprato tutto. Sono quelli che quando ci sono loro, si parla sempre di essere genitori.
Non è vero, diventare genitori è un fatto naturale, non serve prepararsi, basta lasciar succedere le cose e tutto andrà come deve andare. I genitori migliori fanno finta di niente e non hanno bisogno di libri. Giusto una sbirciatina, magari, se le cose si mettono male.
Macché. I genitori migliori, si sa, sono i Francesi.
Si vede che non avete le basi. I genitori migliori sono gli Arapesh della nuova Guinea.
Oggi però i genitori migliori tengono un diario, scrivono un libro, fanno un film, un disco, una mostra per condividere tutti i loro dubbi, le loro emozioni e le cose simpaticissime che succedono loro ogni giorno.
E però basta con questi figli esposti come opere d’arte, non se ne può più di foto, di pensierini, di racconti quotidiani. Per essere dei genitori come si deve, non bisognerebbe parlare dei propri figli. Mai, neanche con loro. Se chiedono qualcosa, tagliare corto e negare tutto. Ma se proprio si deve parlare, dare almeno nomi falsi.
E l'alimentazione?
I neonati devono mangiare solo nelle ore stabilite dal medico di famiglia. Assolutamente no. I neonati devono mangiare continuamente e strillare molto forte quando vanno dal medico di famiglia. I bambini devono mangiare biologico.
No, è tutta una bufala, i bambini devono mangiare roba presa a caso tra quella che costa meno al supermercato.
I bambini vanno nutriti con i vasetti comprati in farmacia. No, i vasetti fanno male ai bambini. Nessuno dovrebbe mangiare vasetti in generale.
Ai figli bisogna dare farina di semi di miglio cotta al vapore.
Ai figli bisogna dare la Nutella.
(Comunque io ve lo dico, mi dispiace per voi ma le cose migliori da far mangiare ai bambini sono quelle che fa mia nonna e basta.)
Apprendimento
I giochi dei bambini devono essere approvati dagli esperti.
Non bisogna dare giocattoli ai bambini, ma lasciare che raccolgano nidi, pergamene, barbabietole e fossili trovati per caso mentre scorrazzano liberi nell'aia.
I genitori migliori giocano con i loro bambini, ma a fine giornata li raccolgono e li mettono a posto.
I bambini possono leggere e scrivere a tre anni.
I bambini non devono assolutamente leggere e scrivere prima dei sette anni.
I bambini devono giocare qualche ora al giorno con il tablet altrimenti non saranno competitivi nel mondo del lavoro.
Non si deve far sapere ai bambini che esistono il computer e la televisione. Se a un certo punto chiedono qualcosa, bisogna dire che non se ne sa niente. Se dovessero insistere si risponde : «Mi dispiace, non riesco a sentirti.»
I genitori migliori sono quelli che leggono ad alta voce.
Ancora migliori sono quelli che leggono ad alta voce quando c’è almeno qualcuno vicino.
Le bambine sono più tranquille dei bambini e leggono prima.
Alle bambine tutti dicono di stare tranquille e allora loro leggono prima perché altrimenti si annoiano.
Le bambine leggono prima dei bambini perché sono più veloci a prendere i libri dagli scaffali e quindi i bambini si agitano perché non hanno nient’altro da fare.
Consigli utili
Ai bambini basta dare poco.
Ai bambini bisogna dare molto.
Bisogna che i bambini si annoino.
Bisogna stimolarli.
L’importante è che si divertano.
L’importante è che si impegnino.
L’importante è seguirli sempre.
L’importante è lasciarli fare.
Bisogna saper dire no. Bisogna saper dire scusami. Bisogna saper dire "Vuoi quei kiwi?".
Quello che conta è l’esempio.
Quello che conta è il dialogo.
Bisogna ascoltarli.
Non devono stare al centro dell’attenzione.
Possono stare al centro, basta che si riesca a vedere il film.
Il bambino non va messo in imbarazzo.
Il bambino non va messo su un piedistallo.
Bisogna scendere al livello del bambino.
Bisogna innalzarsi al livello del bambino.
Bisogna che il bambino si muova.
Bisogna che sappia stare fermo, soprattutto quando è su un piedistallo.
Se i bambini stanno fermi, la terra gira intorno a loro.
Se i bambini girano insieme alla terra, alla fine del giro vogliono fare colazione.
Dopo tanti giri e tante colazioni succede che i bambini un giorno si svegliano e sono grandi. E a quel punto quello che è fatto è fatto.
Riassumendo
I genitori migliori sono quelli che non sanno di esserlo.
No, sono quelli che sanno di esserlo, ma lasciano che siano gli altri a giudicare.
I genitori migliori sono quelli che pensano di essere così così ma non sono sicuri.
No, sono quelli che pensano di essere i peggiori ma poi parlando con altri genitori cambiano idea.
I genitori migliori sono quelli che trovano tempo per se stessi.
I genitori migliori sono quelli che trovano parcheggio.
I genitori migliori sono quelli che quando leggono i manuali dicono ‘aspetta, nell’altro manuale dicevano il contrario’ e allora ne cercano un terzo, un quarto, poi passano a un romanzo, si mettono a chiacchierare e alla fine vanno a letto troppo tardi sapendo che sono rimaste pochissime ore di sonno e pensano: «Vabbè, qualcosa la so. Improvviserò.»