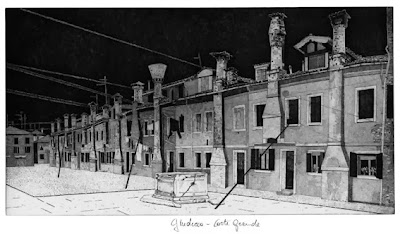Nell'autunno del 1994, Elizabeth Lortic, de Les Tois Ourses, inviò i primi libri di Katsumi Komagata a Bruno Munari, chiedendogli un'opinione. Munari rispose così:
Nell'autunno del 1994, Elizabeth Lortic, de Les Tois Ourses, inviò i primi libri di Katsumi Komagata a Bruno Munari, chiedendogli un'opinione. Munari rispose così:Come una cosa si trasforma in un'altra
Verosimilmente, tutti i bambini del mondo, dopo aver giocato un po' con un giocattolo, finiscono per smontarlo, per vedere come è stato fatto. Allora, gli adulti dicono che il bambino «ha rotto» il giocattolo. Ma non è vero: i bambino lo «apre» per vedere che cosa c'è dentro, come fanno gli adulti, quando «rompono» un'arancia per mangiarla. Nella maggior parte dei casi, non è possibile costruire qualcosa con i pezzi di un giocattolo rotto. A volte è possibile farlo solo con pezzi disparati. Allora, perché non inventare degli oggetti visuali (si è detto un giorno Katsumi Komagata) con pezzi disparati che si possano combinare in modi diversi? Basterà che questi pezzi disparati siano tutti uguali, cioè di dimensioni modulari, in modo da poterli assemblare.
In Oriente, esiste un gioco antichissimo che ha la caratteristica di poter essere composto in una gamma infinita di possibilità: è il tangram. Ma (può darsi abbia pensato Katsumi Komagata) proviamo a giocare, oltre che con i colori, con le forme. Bisogna trovare dei moduli insoliti: un triangolo con un lato curvo, per esempio. In quante forme si può combinare. Vediamo un po'.
Ecco allora una serie di giochi in nero e a colori proposti da Katsumi e adatti anche ai più piccoli.
Gli stessi bambini saranno stupiti da questo cambiamento, molto più di quanto lo siano da certe fiabe che raccontano di un principe innamorato di una bella principessa: ci sono giochi per tutte le età.
Nel 1994, Komagata non era ancora sbarcato in Europa. I suoi primi libri saranno editi in Francia, da Les Trois Ourses nel 1998. I suoi esordi, Komagata li racconta così:
Quando mia figlia ha compiuto tre mesi, ha cominciato a osservare le cose. Non ero sicuro che potesse vedere, ma i suoi occhi si muovevano da sinistra a destra, poi da destra a sinistra. Cominciava anche a guardarmi, come se si domandasse chi fossi. Il padre è meno vicino al bambino della madre, perché la madre e il bambino hanno vissuto insieme per i nove mesi prima della nascita. Così ho pensato a un modo per dire a quella bambina che ero suo padre, e ho cominciato a disegnare delle carte per attirare la sua attenzione [queste carte sono poi diventate la serie "Little Eyes", pubblicata da One Stroke a partire dal 1990 e che vedete nelle pagine del catalogo qui fotografate).
Ho disegnato molte carte, più di cento, per mostrarle alla mia bambina. All'inizio, volevo solo muoverle davanti ai suoi occhi per essere sicuro che ci vedesse. Poi ho capito che erano un mezzo per comunicare con la bambina, anche se non capiva le parole, e che la cosa più importante era condividere qualcosa insieme e divertirsi. Questo è stato il primo passo del nostro dialogo: quello che ci ha permesso di fare conoscenza un po' alla volta.
Ecco, con tutta questa semplicità e purezza sono nati i libri di Katsumi Komagata. Libri importantissimi. Così importanti che spesso ce ne dimentichiamo, come ci dimentichiamo dei libri di Bruno Munari. Ce ne possiamo dimenticare perché sono un po' come la musica di Mozart: qualcosa che abbiamo già dentro, anche se non siamo consapevoli di avercela; e che quando ci viene rivelata magicamente, poeticamente, ci sembra ci appartenga da sempre.
Proprio per questo è particolarmente importante che, a un certo punto, l'opera di questi artisti venga riepilogata, catalogata, esposta ai nostri occhi nella sua interezza, per far sì che ci si possa ricordare, per mai più dimenticare, l'entità del debito che abbiamo nei loro confronti. Come esseri umani, autori, illustratori, editori, bibliotecari, insegnanti, genitori ed ex bambini.
La consapevolezza di questo debito è fondamentale, per non correre il rischio di convincersi di "conoscere e possedere già" l'opera di questi autori, di darla per scontata, di relegarla fra le verità acquisite e le certezze consolidate, quando il pensiero di Komagata, come anche quello di Munari e di Mozart, è un pensiero genuinamente rivoluzionario e, proprio per questo, poco avvezzo a muoversi sul rassicurante terreno delle nostra pretese verità e certezze.
Proprio per questo Les Livres de... Katsumi Komagata, pubblicato nel novembre del 2013 da Les Trois Ourses è un libro essenziale. Essenziale quanto quella barra di platino iridio conservata a Sèvres, al Bureau Internationale des Poids et des Mesures che, dal 1899 ci dà la misura di tutte le cose.
Nel 2008, in un numero speciale della rivista "Le Mook": Quand les artistes créent pour les enfants. Des objets livres pour imaginer, dedicato ai primi vent'anni di attività di Les Trois Ourses, Katsumi Komagata ha scritto:
Recentemente, mia figlia mi ha domandato se avrei continuato a creare libri per bambini così pieni di sorprese e di cose strane. Le ho risposto: «Lo farò.»
E noi aspettiamo i suoi libri, ogni volta con l'ansia e l'aspettativa di quando eravamo bambini.
I precedenti post della rubrica "Leggere l'illustrazione" sono stati dedicati a: